Don Giuseppe De Luca nacque a Sasso di Castalda il 15 Settembre 1898 da Vincenzo De Luca e Raffaella Viscardi. Trascorse la fanciullezza a Brienza, piccolo borgo poco distante da Sasso, in casa della nonna materna, essendogli venuta a mancare la madre, colpita da febbre puerperale. Dopo due anni di seminario a Ferentino, nel 1911 venne a Roma ed entrò al seminario minore, allora ubicato nell’edificio di S.Apollinare, seminario prestigioso, organico alla Roma ecclesiastica da cui uscì un clero, che con termine familiare, fu chiamato «romano». Nel 1914 passò al seminario maggiore che aveva sede in S.Giovanni in Laterano, ove ebbe docente, fra gli altri, nel quadriennio di teologia dal 17 al 21, lo storico Pio Paschini, di cui ritenne il modo scabro, essenziale, senza fervori, di fare lezione di Storia.
Nel 1920 si iscrisse al corso di paleografia e diplomatica del Vaticano e alla facoltà di lettere di Roma, dove strinse rapporti di amicizia e di lavoro con Vittorio Rossi, Nicola Festa, Ettore Pais, Giovanni Gentile e Ernesto Buonaiuti. «Giovane - ricordò il De Luca in una lettera a B.L.Ullman – avevo cominciato filologo, e dovevo dare con Nicola Festa la Poetica di Aristotele in edizione critica, o meglio, nella storia del testo; passai quindi con Vittorio Rossi, e molta della prima ricerca fu cosa mia. Non prese mai la laurea in lettere, preferendo la frequentazione assidua delle biblioteche e degli archivi e accumulando una quantità sterminata di note e schede, attraverso la lettura di codici e manoscritti medioevali e moderni, che ne fecero, ancora giovane, un prezioso suggeritore di ricerche e di studi. Ebbe sempre una sconfinata ammirazione per il mondo della grande erudizione ecclesiastica. Ebbe ancora il tempo di vedere, fra gli altri, Franz Ehrle e Louis Duchesne. Fra il 1924 e il 1935, pur continuando ad alimentare con numerose ricerche il progetto di una storia della pietà, si impegnò in una intensa attività giornalistica ed editoriale nel campo cattolico. Contemporaneamente alla sua collaborazione con
Azione cattolica, si svolgevano i rapporti di proficua Fra il 1930 e il 1940 il De Luca era presente su L’Osservatore romano e L’Avvenire con nutrite e numerose recensioni erudite e letterarie. Tenne lezioni di letteratura, iconografia e arte sacra in diversi istituti cattolici, collaborò dal 1930 all’Enciclopedia Italiana, diresse per la Morcelliana le collane «Per verbum ad verbum», «I compagni di Ulisse» «Confidenziali» Più tardi, nel 1942, diresse «I fuochi», fortunata collana, sempre della Morcelliana. La sua grande erudizione, le sue qualità anche letterarie, la sua umanità ne fanno un interlocutore ricercato e prezioso per il mondo anche degli scrittori: suoi amici erano Papini, Prezzolini, Giuliotti, Ungaretti, Bo, Betocchi, Baldini, Cardarelli, D’Amico, Cecchi, Palazzeschi, Pancrazi. Fra i politici contava G.Bottai, amicizia che continuò anche dopo la fine del conflitto. Il D. cercò di convincere Bottai, negli ultimi anni del fascismo, a farsi patrocinatore di una struttura culturale capace di ricomporre la interrotta tradizione tra pensiero medioevale e cultura moderna. Il De Luca aveva indicato come suoi maestri per la sua «storia della pietà» tre francesi: Andre Wilmart, «1’erudito errante e monaco stabile», Henri Bremoiid, «scrittore fortunato e fortunoso», e Joseph de Guibert, «piissimo, paterno e fraterno teologo» Dunque, dalla storia narrata il De Luca passò
all’inventario dei contenuti di questa possihile storia. Il progetto era già chiaro
nel 1941, quando redigeva lo schema del suo prossimo lavoro ed avvertiva che nel campo
storico non si era ancora arrivati «alla fede delle masse semplici, le quali sono rimaste
folklore pei profani; greggie pei chierici». Nello stesso anno studiava anche il piano di
pubblicazioni per una nuova casa editrice, in collahorazione con Alfredo Schiaffini, le
Edizioni di storia e letteratura, che incominceranno a svolgere le attività nel 1942.
Anno cruciale, di crisi aperta a causa della «marea montante della violenza e
dell’odio, del barbarico azzardo cui era commesso il destino dei popoli cosiddetti
civili». I primi nomi che figurano nelle Edizioni indicano già la direzione in cui
originariamente si mosse il De Luca: oltre Schiaffini, ci sono i nomi di Wilmart, Oliger,
Paschini, Nardi, Ciampini, Billanovich, Dionisotti, Scaduto, Jedin, Maier, Angelo Mercati,
Vaccari, Massimo Petrocchi, Campana, Importanti e ricchi di progetti i pochi anni che il De Luca trascorse vicino a Giovanni XXIII (1958-63), che già durante il periodo che fu patriarca a Venezia a lui si rivolse per consiglio nello studio della pietà veneziana, in particolare della figura di Lorenzo Giustiniani. Della stima e dell’amicizia che Giovanni XXIII nutri per il De Luca e segno prima la sua nomina a consultore, poi a membro della Pontificia Commissione preparatoria degli studi e dei seminari. Il De Luca ebbe rapporti anche con i politici del secondo dopoguerra (Togliatti, Rodano, Colombo, De Gasperi, Sturzo, Segni, Morlino, Campilli ed altri), per lo più indirizzati a ottenere aiuti per i suoi progetti editoriali: con Emilio Colombo discusse in più riprese il problema della salvaguardia delle biblioteche e degli archivi ecclesiastici e privati della sua Lucania; ad altri, a Luigi Sturzo, ad Alcide De Gasperi, a pietro Campilli chiedeva contributi per le collane delle sue edizioni. Nel 1951 finalmente usci la sua tanto elaborata, ripensata e tormentata introduzione al primo volume dell’Archivio italiano per la storia della pietà, sintesi e capolavoro del De Luca, come storico e scrittore dalla prosa «procellosa e ridente» Qui il De Luca dava infine la definizione della sua «pietà»: «Riceve qui il nome di pietà non la teoria sola o il solo sentimento dell’una o dell’altra religione in genere, non la sola religiosità vaga, non il solo vertice supremo ed esatto dell’unione mistica, bensì quello stato, e quello solo della vita dell’uomo quando egli ha presente in se, per consuetudine di amore, Iddio"Il De Luca si spense a Roma nell’ospedale dei Fatebenefratelli, all’isola Tiberina, il 19 Marzo 1962. Qualche giorno prima della scomparsa ricevette la visita di Giovanni XXIII.
|
 Fu ordinato sacerdote il 30 ott.
1921; nell’ autunno del 1923 fu nominato cappellano dei vecchi poveri, ospitati dalle
piccole suore dei poveri nella casa di piazza S.Pietro in Vincoli. Qui venne anche
raccogliendo quella che sarebbe stata una delle più ricche biblioteche private di testi
antichi e moderni di Roma, notevolissima per le cinquecentine, e per i titoli attinenti
alla storia religiosa e della spiritualità. Fu cappellano fino al 1948.
Fu ordinato sacerdote il 30 ott.
1921; nell’ autunno del 1923 fu nominato cappellano dei vecchi poveri, ospitati dalle
piccole suore dei poveri nella casa di piazza S.Pietro in Vincoli. Qui venne anche
raccogliendo quella che sarebbe stata una delle più ricche biblioteche private di testi
antichi e moderni di Roma, notevolissima per le cinquecentine, e per i titoli attinenti
alla storia religiosa e della spiritualità. Fu cappellano fino al 1948. 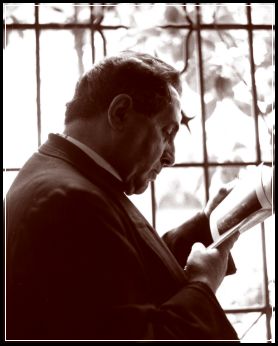 amicizia e
attività culturale ed editoriale fra il De Luca e Giovanni Papini. L’amicizia fra i
due si fece presto profonda: fra 1’altro, i due collaborarono fra il 1930 e il 1940
alla rivista, diretta da P.Bargellini, Il Frontespizio . Il De Luca divenne presto
la figura determinante nell’organizzazione della rivista stessa, colui che fornì il
sottofondo culturale e indispensabile a che la rivista potesse acquistare una funzione e
un ruolo nazionale.
amicizia e
attività culturale ed editoriale fra il De Luca e Giovanni Papini. L’amicizia fra i
due si fece presto profonda: fra 1’altro, i due collaborarono fra il 1930 e il 1940
alla rivista, diretta da P.Bargellini, Il Frontespizio . Il De Luca divenne presto
la figura determinante nell’organizzazione della rivista stessa, colui che fornì il
sottofondo culturale e indispensabile a che la rivista potesse acquistare una funzione e
un ruolo nazionale. 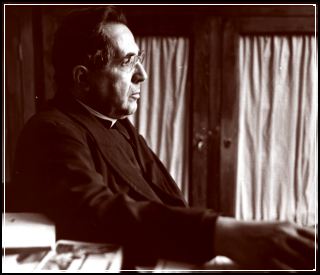 Christine
Mohrmann, Branca, Batllori, tutti autori che divennero poi amici. Fin dagli inizi, il De
Luca dette alla sua casa editrice l’impronta di un’accademia scientifica sui
genesis, di promozione e di aiuto anche ai giovani autori. Con la nascita
dell’editore, finiva nel De Luca il poco sicuro ruolo di mediatore di una nuova
cultura politica nazionale.
Christine
Mohrmann, Branca, Batllori, tutti autori che divennero poi amici. Fin dagli inizi, il De
Luca dette alla sua casa editrice l’impronta di un’accademia scientifica sui
genesis, di promozione e di aiuto anche ai giovani autori. Con la nascita
dell’editore, finiva nel De Luca il poco sicuro ruolo di mediatore di una nuova
cultura politica nazionale.